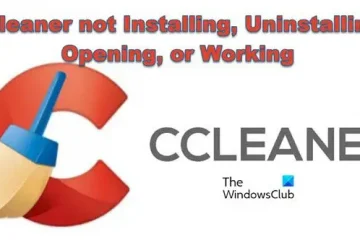Scarica ora il libro completo nel negozio di Bitcoin Magazine.
Questo articolo fa parte di una serie di estratti adattati da”Bitcoin Is Venice”di Allen Farrington e Sacha Meyers, disponibile per acquista ora sullo store di Bitcoin Magazine.
Puoi trovare gli altri articoli della serie qui.
“Non c’è niente di nuovo tranne ciò che è stato dimenticato.”
Pensiamo che ci sia del merito nel guardare alla storia per esplorare il paesaggio del capitale in tutte le sue forme in un tempo e in un luogo in cui l’investimento era preso sul serio, non solo come esercizio finanziario, ma come risultato naturale della salute spirituale e comunitaria. Sia nel fiorire della produzione artistica che nell’abbraccio della rivoluzione commerciale su cui si basava questa produzione, la Firenze rinascimentale è un candidato ideale, come Roger Scruton avrebbe probabilmente apprezzato.
Il commercio fu il fulcro dell’ascesa di Firenze dal Medioevo e le finte istituzioni repubblicane della città le garantirono una relativa stabilità, una precondizione necessaria per accumulo di capitale. Sebbene i diritti di proprietà non fossero al di fuori dell’ingerenza delle famiglie più ricche che inseguivano i loro rivali, il sistema fiorentino forniva ai mercanti protezione reciproca in patria e dagli altri all’estero. In netto contrasto con la sua storia medievale, Firenze era giunta ad essere governata da una classe di persone interessate ai profitti commerciali piuttosto che alla conquista della terra. La forza servirebbe il commercio salvaguardando la proprietà, assicurando contratti e mantenendo aperte le rotte commerciali. Erano finiti i giorni delle famiglie aristocratiche in lotta per il controllo dei seminativi. Simbolo di questo nuovo sistema era la moneta fiorentina, il fiorino. Come Paul Strathern spiega:
“La supremazia bancaria di Firenze e l’affidabilità dei suoi banchieri hanno portato la valuta della città a diventare un’istituzione. Già nel 1252 Firenze aveva emesso il fiorino d’oro, contenente cinquantaquattro grani d’oro, che divenne noto come fiorino. A causa del suo contenuto in oro immutabile (una rarità nelle monete dell’epoca) e del suo utilizzo da parte dei banchieri fiorentini, il fiorino fu accettato durante il XIV secolo come valuta standard in tutta Europa.”
Richard Goldthwaite individua l’interrelazione tra la bellissima architettura, la fioritura culturale e il successo economico, scrivendo in “L’economia della Firenze rinascimentale”:
“La migliore prova del successo dell’economia, tuttavia, sono le sue manifestazioni fisiche all’epoca, e queste sono drammatici come possono essere queste cose. Nel 1252 Firenze conobbe il suo primo fiorino d’oro, e alla fine del secolo il fiorino era la moneta universale nei mercati commerciali e finanziari internazionali di tutta l’Europa occidentale… Nel 1296 fu progettata una nuova cattedrale e quando, dopo due decisioni successive di aumentarne la grande, fu dedicata al completamento della sua grande copula nel 1436, era la cattedrale più grande, e forse la più grande chiesa di qualsiasi tipo, d’Europa. Nel 1299 iniziarono i lavori per il grande salone pubblico della città, che è stato definito uno degli edifici più originali dell’Italia medievale. La moneta internazionale standard dell’epoca, una delle più grandi mura di qualsiasi città europea, quella che sarebbe diventata la più grande cattedrale della cristianità e una massiccia e originale sede del governo non erano indicatori insignificanti del successo dell’economia fiorentina a l’epoca in cui Dante e Giotto erano sulla scena”.
Da questa crescita del commercio sono nate le banche. I mercanti che commerciavano merci in tutta Europa avevano il controllo di sempre più risorse. Esattamente nel senso descritto da Hernando de Soto, il quadro giuridico sostenuto dai fiorentini-e da città-stato mercantili dell’Italia settentrionale come Venezia, Pisa, Genova e Siena-consentiva di utilizzare come capitale semplici beni. Le famiglie di banchieri come i Medici iniziavano spesso un mestiere, come la lana, e fornivano ai mercanti in competizione capitale circolante. L’attività bancaria non era quindi un’attività puramente finanziaria. Rimase saldamente radicata nell’impresa. I banchieri fiorentini erano prima di tutto mercanti che capivano cosa ci voleva per gestire un’impresa.
Tra le grandi famiglie di banchieri della Firenze tardomedievale e rinascimentale e forse anche dell’Italia, nessuna brilla così brillante come i Medici. Eppure le tre grandi famiglie fiorentine del XIV secolo, gli Acciaiuoli, i Bardi e i Peruzzi, controllavano un tempo banche più estese e più ricche di quelle dei Medici. Né i Medici furono banchieri particolarmente innovativi. Secondo Strathern, i Medici erano infatti conservatori nella loro impresa:
“Giovanni di Bicci era un uomo prudente e preferiva consolidarsi. Questo era un tratto che condivideva con il suo predecessore come capo del clan dei Medici, suo lontano parente Vieri, e lo trasmise certamente al figlio; come banchieri, i Medici guadagnavano con cautela ed efficienza, piuttosto che con l’innovazione. Contrariamente alla tradizione bancaria, non hanno inventato la cambiale, sebbene possano aver contribuito all’invenzione della holding; il loro successo si basava quasi esclusivamente sull’uso di tecniche collaudate sperimentate da altri. Il Banco dei Medici non ha mai subito una rapida espansione, e anche al suo apice non è stato così esteso come nessuna delle tre grandi banche fiorentine del secolo precedente.”
Eppure, il successo o l’innovazione finanziaria è non perché il nome Medici abbia fatto eco nei secoli. I Medici erano banchieri di successo, ovviamente. Hanno fatto fortuna con il commercio europeo della lana, con filiali lontane da casa come Londra e Bruges. Il loro controllo sia sui conti pontifici che sul commercio dell’allume, che era stato monopolizzato da Roma, forniva profitti affidabili al riparo dalla concorrenza. Ma la leggenda dei Medici è nata investendo non in banche e nemmeno nel commercio, ma in progetti culturali immateriali che avrebbero prodotto rendimenti impossibili da misurare. Attraverso il mecenatismo, i Medici avrebbero destinato i capitali, accumulati attraverso attività bancarie meticolose e conservatrici, a iniziative di cui nessun contabile avrebbe potuto avere un senso. Eppure, il valore creato dai Medici sopravvive a quello delle famiglie italiane di maggior successo finanziario.
Poiché i banchieri fiorentini potevano fare affidamento su denaro duro per fare investimenti ragionevoli, capivano la semplice verità dietro l’accumulo di ricchezza. I loro incentivi erano semplicemente non massimizzare il flusso. Diremmo che è questa profonda comprensione intuitiva della ricchezza che ha portato i mercanti, in particolare i Medici, ad accumulare capitale culturale attraverso la spesa per le arti e le scienze. Infatti, come scrive Strathern, i Medici investirono in capitale culturale perché era il bene più difficile che conoscessero:
“Fu solo negli ultimi anni che Giovanni di Bicci aveva cominciato a capire che c’era di più alla vita rispetto al sistema bancario e ai rischi che ne derivano. Il denaro poteva essere trasformato nella permanenza dell’arte dal mecenatismo, e nell’esercizio di questo mecenatismo si accedeva a un altro mondo di valori senza tempo, che appariva libero dalla corruzione delle autorità religiose o dalle subdole politiche del potere e delle banche.
I Medici hanno depositato il loro capitale finanziario in capitale culturale che sarebbe sopravvissuto a tutti loro in una bellezza che rimane utile secoli dopo la scadenza di qualsiasi utilità commerciale transitoria. Come Cosimo de’Medici ha detto:”Conosco le vie di Firenze, tra cinquant’anni noi Medici saremo stati esiliati, ma i miei edifici rimarranno”.
In un certo senso Cosimo era troppo ottimista. I Medici furono esiliati entro 30 anni. Ma gli edifici rimangono, insieme al nome dei Medici. La cupola del Brunelleschi, che sovrasta il Duomo di Firenze, e artisti come Michelangelo e Leonardo da Vinci furono al centro del Rinascimento, che si diffuse da Firenze in tutta Europa e poi nel mondo. Tutti hanno un debito di gratitudine verso i Medici.
Robert S. Lopez caratterizza questo straordinario effetto sociale e culturale che si diffuse da Firenze e Venezia negli ultimi paragrafi de”La rivoluzione commerciale del medioevo, 950–1350”, scrivendo:
“Senza dubbio c’erano molte persone che si lamentavano del fatto che prestatori di denaro alieni venivano’con nient’altro che una penna e un calamaio’per annotare le anticipazioni fatte a re o contadini sotto forma di semplici buoni, e in cambio di tali scarabocchi alla fine si portarono via la ricchezza materiale della terra. Ma i mercanti scrivevano anche libri in gran numero. Non è un piccolo segno della loro ascesa nel XIII e all’inizio del XIV secolo che il libro più copiato e letto sia stato quello di Marco Polo, dove l’informazione pratica sui mercati si intreccia con il romanzo del viaggio, e che il più grande poema dell’intero medioevo fu scritto da Dante Alighieri, iscritto se non attivissimo membro della corporazione fiorentina dei mercanti di spezie. I mercanti costruirono anche municipi, arsenali, ospedali e cattedrali. Quando la Grande Peste colpì, Siena aveva appena iniziato a lavorare su un’estensione del suo incantevole Duomo, in modo che potesse superare la cattedrale dei suoi vicini e rivali commerciali di Firenze.
Oltre la generosità dei Medici era una profonda comprensione degli investimenti. Nonostante i benefici culturali non fossero così chiaramente misurabili come i rendimenti finanziari, banchieri come Cosimo de’Medici sapevano come ottenere il meglio da artisti capricciosi. Secondo Strathern,”Cosimo potrebbe essere stato conservatore nella sua pratica bancaria e potrebbe essersi comportato consapevolmente in modo modesto e riservato, ma sorprendentemente era in grado di tollerare il comportamento più stravagante tra i suoi protetti”.
Come Cosimo lo stesso una volta disse: “Bisogna trattare queste persone di straordinario genio come se fossero spiriti celesti, non come se fossero bestie da soma.”
Il profilo di rischio dell’investimento culturale ricorda più il capitale di rischio di quanto non lo sia il progetto relativamente stupido del merchant banking: molti falliranno, ma alcuni potrebbero avere successo oltre le tue più rosee aspettative. Abbracciare l’asimmetria dei risultati è la chiave del successo.
È alleando sia il prestito conservatore che il mecenatismo solidale che i Medici sono riusciti ad accumulare prima capitale finanziario e poi culturale come pochi prima o dopo. Per questo i tre grandi Medici-Giovanni di Bicci, Cosimo de’Medici e Lorenzo il Magnifico-sono dei capitalisti culturali esemplari, essendo i primi due anche scaltri capitalisti finanziari. Hanno mobilitato capitali privati per promuovere un ambiente di eccezionale creatività culturale. Strathern riassume perfettamente il genio dei Medici:
“La nuova arte può aver richiesto la scienza, ma ha anche richiesto il denaro, e questo è stato in gran parte fornito da Cosimo, che secondo uno storico ammirato’sembrava determinato a trasformare la Firenze medievale in una città rinascimentale completamente nuova.» Non si trattava di un’esagerazione, perché Cosimo finanziò la costruzione, o ristrutturazione, di edifici che andavano dai palazzi alle biblioteche, dalle chiese ai monasteri. Quando suo nipote Lorzen il Magnifico esaminò i libri molti anni dopo rimase sbalordito dalle somme che Cosimo aveva investito in questi schemi; i conti rivelerebbero che tra il 1434 e il 1471 erano stati spesi l’incredibile cifra di 663.755 fiorini d’oro… Una tale somma è difficile da contestualizzare; basti pensare che poco più di un secolo prima l’intero patrimonio della grande Banca Peruzzi al suo apice, accumulato in filiali in tutta l’Europa occidentale e che si estendeva oltre a Cipro e Beirut, equivaleva a 103.000 fiorini d’oro.
“Eppure tale munificenza è sempre stata costruita sulle fondamenta di una solida pratica bancaria. Dall’esame delle scritture della Banca Medici emerge che, pur avvalendosi dei più efficienti strumenti finanziari disponibili, non era in alcun modo innovativa nelle sue pratiche; era se non altro molto conservatore rispetto ad altre istituzioni simili. Né Giovanni di Bicci né Cosimo de’Medici hanno introdotto nuovi metodi o modi di fare affari, la loro pratica è interamente basata sull’uso efficiente e prudente di metodi collaudati sperimentati da altri.”
It Può sembrare strano sostenere la salute di una società rinascimentale rispetto alla povertà relativa della nostra, soprattutto alla luce dei miglioramenti in quasi ogni metrica sensata della prosperità umana in linea con il maggiore sfruttamento dell’energia dopo la rivoluzione industriale. Ma la nostra valutazione della salute e della povertà riguarda più l’atteggiamento che il risultato.
Non possiamo aiutare le dimensioni del ceppo che ereditiamo dai nostri antenati; possiamo solo decidere cosa farne e come mirare a trasmetterlo a nostra volta. L’imperativo di decidere è radicato in tutti gli stock di capitale nella scarsità di tempo e di energia e quindi il nostro atteggiamento nei confronti della scarsità stessa è alla base di ciò che sarà il capitale economico, sociale e culturale allo stesso modo. L’atteggiamento degenerato della fiat è stato quello di ottimizzare l’efficienza e i risultati su tutte le forme di capitale sono stati a dir poco catastrofici.
Jane Jacobs sottolinea con forza questo punto nel minacciosamente intitolato”Dark Age Ahead“, scrivendo:
“Forse la più grande follia possibile per una cultura è cercare di superare se stessa utilizzando principi di efficienza. Quando una cultura è abbastanza ricca e intrinsecamente complessa da permettersi la ridondanza di coloro che si prendono cura di loro, ma li elimina come una stravaganza o perde i loro servizi culturali per incuria di ciò che si sta perdendo, la conseguenza è un genocidio culturale autoinflitto. Poi guarda le spirali viziose entrare in azione”.
La celebrazione nervosa dell’idiozia borbottante politicamente corretta è solo una delle conseguenze del genocidio culturale di cui Jacobs ha messo in guardia. È una conseguenza dell’impazienza e del risentimento, e del rifiuto dei principi abbracciati dai Medici, che la creazione del capitale culturale è l’investimento più valido di tutti. Perché qual è il suo “ritorno”? Qual è il suo “profilo di rischio”? Trovare e finanziare un Brunelleschi potrebbe essere un colpo su mille o uno su un milione.
Potrebbero volerci decenni per ripagare poiché il talento viene coltivato fino al punto di possibilità di un concepibile rimborso del capitale , qualora un calcolo così dubbio fosse ritenuto utile. Lo shock, invece, è istantaneo e garantito. Qualsiasi hack senza talento può scioccare un pubblico che si aspetta meriti non riuscendo a produrne in modo aggressivo. E che dire dei tratti caratteriali instillati da tale spazzatura implacabile, risentita, impaziente, falsa e che vive di bugie? Quali possono essere le conseguenze dell’abbandono della difficoltà della ricerca della verità sociale per la facilità dell’isolamento oppressivo? Quali sono le conseguenze per la salute mentale? Riusciremo a produrre uomini e donne forti, in grado di affrontare l’incertezza fondamentale della vita armati della capacità di generare conoscenza pratica? Produrremo comunità solide e spirito civico? Produrremo verità, bontà o bellezza? Produrremo conoscenza?
No, non lo faremo.
Produrremo narcisisti; facilmente manipolabile dall’avidità e dalla paura, incline al solipsismo, all’irrazionalità, alla dipendenza, alla fragilità e al panico, i cui incentivi sono così deformati da rendere il doppio egoismo una necessità di navigazione sociale e sopravvivenza; ottimizzato per il capitale di strip mining e non molto altro; che si gireranno indietro e marceranno attraverso istituzioni nominalmente dedicate al nutrimento, al rifornimento e alla crescita di una o altra forma di capitale, dirottando e riproponendole in emittenti di narcisismo. In”La cultura del narcisismo“, Christopher Lasch ha previsto altrettanto:
“Le istituzioni di trasmissione culturale (scuola, chiesa, famiglia), che avrebbero dovuto contrastare la tendenza narcisistica della nostra cultura, sono state invece plasmate a sua immagine, mentre un corpo crescente di la teoria giustifica questa capitolazione sulla base del fatto che tali istituzioni servono al meglio la società quando forniscono un riflesso speculare di essa. Di conseguenza, continua la deriva discendente dell’istruzione pubblica: la costante diluizione degli standard intellettuali in nome della rilevanza e di altri slogan progressisti; l’abbandono delle lingue straniere; l’abbandono della storia a favore dei”problemi sociali”; e un ritiro generale dalla disciplina intellettuale di qualsiasi tipo, spesso resa necessaria dalla necessità di forme disciplinari più rudimentali al fine di mantenere standard minimi di sicurezza.
Rifiuto della grande arte e letteratura — se sulla base del”sentimentalismo borghese”in un’epoca, del cinismo alla moda ironico in un’altra, dell'”irrilevanza”e del favorire i”problemi sociali”in un’altra ancora, non è affatto diverso dalla confisca del capitale fisico: recide un legame con il passato e ci rende incapaci di imparare dall’esperienza cumulativa delle nostre comunità. Ci rende allo stesso tempo dipendenti e soli. La vera tragedia dell’appropriazione politica del capitale produttivo non è tanto la violenza del furto, ma il rendimento abortito che potrebbe essere scaturito dal bene perché il controllo è trasferito a chi non ha idea di cosa stia facendo. Non hanno la conoscenza e la competenza per ricostituire persino il capitale, non importa se continuano a raccoglierne la produzione.
Questa separazione tra controllo e conoscenza; la distruzione del tempo pazientemente immagazzinato; la revoca della volontà di rischiare e di sacrificarsi per costruire, provocherà un parallelo straziante a una spirale di debiti che crolla: una spirale che crolla del sapere come fare. Bisognerà riscoprirli. Farlo non sarà piacevole.
Lo stesso vale per la letteratura e l’arte: finiremo con una cultura che semplicemente, tragicamente, non sa nulla. Eppure, composto di esseri umani così com’è, dovrà comunque affrontare ogni esigenza che la letteratura e l’arte soddisfano, e quindi dovrà improvvisare simulacri impoveriti al posto della cosa reale. In uno dei momenti più sorprendenti di “Why Beauty Matters, Scruton intervista Alexander Stoddart, il celebre scultore i cui monumenti di giganti intellettuali scozzesi come David Hume, Adam Smith, William Playfair e James Clerk Maxwell adornano magnificamente le strade di Edimburgo. Stoddart descrive:
“Molti studenti vengono da me dai dipartimenti di scultura-ovviamente in segreto-perché non vogliono dire ai loro tutor che sono venuti a guidare il nemico. E dicono:’Ho provato a fare una figura modello, e l’ho modellata con l’argilla, e poi il tutor si è avvicinato e mi ha detto di tagliarlo a metà e di versarci sopra un po’di diarrea, e questo lo renderà interessante.'”
Scruton concorda:”È quello che provo riguardo al tipo di profanazione standardizzata che passa per arte in questi giorni — in realtà è una sorta di immoralità perché è un tentativo di cancellare il significato da la forma umana”.
E Stoddart risponde ferocemente:”Beh, è un tentativo di cancellare la conoscenza”.
La produzione di cultura che ne risulterà sarà prevedibilmente immatura e superficiale perché ci siamo resi inconsapevoli di storia e hanno reciso il legame con ciò che è già stato appreso. In un podcast, Wynton Marsalis risponde alla domanda di Jonathan Capehart se sia giusto definirlo un”uomo di razza”oltre che un”uomo del jazz”dicendo:”Sì, è giusto”. Capehart gli chiede di”definirlo”e Marsalis risponde:
“Penso che sia una persona orgogliosa di qualunque sia la sua sottocultura o sottogruppo, in questo caso i neri americani. Non significa che sei contro le altre persone, ma sei consapevole della storia della tua sottocultura e la accetti, ci credi e non ti dispiace parlarne.”
Riteniamo che Lin-Manuel Miranda sia un maestro contemporaneo di un abbraccio orgoglioso e celebrativo dell’etnia subculturale e, di conseguenza, un’arte che si trova a cavallo dell’isolamento del finto daltonismo e dell’oppressione del razzismo imponente. Il suo lavoro è eccezionale capitalismo culturale. Il suo musical più noto,”Hamilton”, attinge e reinventa il mito fondatore comune utilizzando il nuovo linguaggio dell’hip-hop e la nuova realtà della diversità etnica americana. Il risultato è un’opera d’arte davvero inclusiva che invita tutti a unirsi e fornisce un nuovo obiettivo di comprensione. È impegnativo ma rispettoso. È intimamente consapevole del suo canone-non solo letterario ma sociale e culturale-eppure trova una nuova combinazione di espressioni, così originale e potente da estendere il significato del canone.
“In The Heights”va anche ulteriormente nella sua implicita celebrazione dell’America e potrebbe benissimo essere l’opera d’arte più sottilmente ma sfacciatamente filo-americana di cui siamo a conoscenza. Il musical, anch’esso recentemente adattato in un film, fonde una celebrazione della cultura dominicana e, più in generale, latino-americana con commenti acuti sulle lamentele razziali, eppure evita del tutto il risentimento e la segregazione. Il messaggio è inequivocabilmente che l’infusione nella corrente principale della cultura latino-americana migliora la cultura americana nel suo insieme per tutti. Facendo eco a Martin Luther King, Jr., più questo accade in modo positivo e organico, meglio è. L’imposizione centrale sulla base del risentimento provocherà a sua volta solo un risentimento uguale e opposto, e inoltre è un insulto ai meriti intrinseci della cultura che viene difesa. Il viaggio di diversi personaggi è segnato dal passaggio nella loro autoidentificazione culturale dall’amarezza e dall’opposizione alla fiducia e alla celebrazione; potremmo dire, dalla derisione alla creazione.
“In The Heights” si impegna a testimoniare che questa cultura (poiché tutta la cultura è locale e specifica) è, nel suo nucleo sociale e spirituale, tanto americana quanto arrivano. È radicato nel duro lavoro e nel sacrificio, nell’abbraccio delle opportunità, nell’amore per la comunità e nel rispetto per la sua cultura e la sua letteratura. La bellissima canzone solista della matriarca Abuela Claudia,”Pacienza Y Fe”, incarna l’etica del musical: pazienza e fede. A lungo termine, impegno e rifiuto del cinismo. Coscienziosità, riverenza e responsabilità. Non c’è sicuramente integrazione più intima e impegnata del dare al proprio figlio il nome di un elemento della società ospitante, non meno un elemento integrante dell’esperienza dell’immigrazione, come è il personaggio principale Usnavi, dal nome che i suoi genitori hanno interpretato erroneamente di un U.S. Nave della Marina che hanno superato quando sono arrivati per la prima volta in America. Facendo leva sul”potere”come nell’elettricità o nell’influenza sociale, Usnavi incoraggia i membri della sua comunità durante un’interruzione di corrente:
“Va bene, siamo impotenti, quindi accendi una candela.
“Non sta succedendo niente qui che non possiamo gestire.”
Difficilmente potremmo trovare uno slogan migliore di localismo, sperimentazione e coordinamento sociale dal basso verso l’alto se ci provassimo.”In The Heights”è buono. È artisticamente buono, ma soprattutto è moralmente buono. Miranda è tra i più grandi capitalisti culturali del nostro tempo.
Questo è un guest post di Allen Farrington e Sacha Meyers. Le opinioni espresse sono interamente proprie e non riflettono necessariamente quelle di BTC Inc o di Bitcoin Magazine.